Parlare di “cura“, quando si parla di disturbi dell’alimentazione, o di disagio psichico in genere, è una cosa controversa e complicata, soprattutto quando si sperimentano tentativi, fallimenti e ricadute continue sulla propria pelle. Potrei trattare il tema dal punto di vista clinico, potrei soffermarmi ad interrogarmi una volta per tutte su uno dei leitmotiv di chi si occupa di psichiatria critica oggi, gli psicofarmaci, e il loro valore (o non valore) nella realtà dei processi di cura. Non lo farò, o almeno non oggi, non stavolta: non credo di essere ancora pronta a risolvere questo conflitto, non credo di averlo ancora superato, non sono abbastanza lucida. Potrei, di contro, scatenare conflitti tra me e me, sul senso generale dei discorsi sulla “cura”: ha senso parlarne o sarebbe più onesto parlare di periodi più o meno lunghi di remissione, di miglioramenti temporanei di cui approfittare prima di precipitare di nuovo? E tornando al clinico, ha senso parlare di “cura” in psichiatria, o si può parlare sempre e solo di palliativi?
L’unica risposta che ho, non è una risposta medica. E’ una risposta militante: più che parlare di “cura”, a me piace parlare sempre di resistenza al disagio, mi piace pensare di avere una Kobane nel cervello. Mi piace parlare dei periodi di remissione e dei miglioramenti come periodi di rivolta gioiosa, di insurrezione, di creazione di un ordine mentale alternativo a quello imposto dai dispositivi della malattia.
Poi, naturalmente, c’è la questione della collettivizzazione, che è una roba di cui ho sempre parlato su questo blog (e sul vecchio) e in particolare attraverso questa cosa di Due dita in gola. La resistenza alla malattia è un atto politico e pertanto deve necessariamente essere un processo collettivo e anche questa autonarrazione, come chi segue questo blog da tempo probabilmente saprà, è un atto di collettivizzazione e di controinformazione, un manifesto in più atti discontinui che si può riassumere e condensare nei termini della necessità di prendere coscienza del fatto che il personale è politico e di prenderne coscienza talmente tanto da arrivare al passaggio successivo: l’interiorità psichica è politica. Nelle pratiche, purtroppo, sebbene del fatto che il personale è politico si parli più o meno da quarant’anni, il terreno è ancora accidentatissimo. Ma le resistenze sono accidentate. Sempre.
Le resistenze, poi, si fanno anche attraverso le decostruzioni delle narrazioni dominanti. Ad esempio c’è la retorica della cura come processo individuale, del trovare dentro di sè la forza, del vedere la propria bellezza interiore e tutta la roba motivazionale trita e ritrita che prima girava solo in libri spazzatura e nei talk-show e adesso straborda da qualsiasi buco del web. Ingenuamente, fino a qualche anno fa, mi limitavo a bollare queste rappresentazioni dei processi di cura come banalità criptoecumeniche, come qualunquismi applicati al disagio. A rifletterci bene, invece, si tratta di una vera e propria rappresentazione capitalistica della cura, un mix di stevejobsianesimo di nuovo corso e di vecchia narrazione del self-made-man all’americana. Gente che ne esce fuori da sola. Startupper del disagio. Anzi, non ditelo a Matteo Renzi e alla sua banda, potrebbero inventarsi qualche stronzata per infliggere ulteriori tagli a quel poco di Sanità Pubblica che è rimasta.
Sul versante completamente opposto c’è Silver Linings Playbook (titolo come al solito tradotto di merda in Italia, “Il lato positivo”, ndr). E’ un filmetto godibile, Jennifer Lawrence ha vinto l’Oscar come Migliore Attrice, c’è Bradley Cooper, c’è Robert De Niro, e a caldo, a noi della frangia romantica dell’alterpsichiatria era pure piaciuto, perchè offriva una rappresentazione non clinicizzata della cura. Sembrava fighissimo e invece – a rifletterci a freddo, e nell’ottica della reinterpretazione militante dei processi di resistenza al disagio – anche le narrazioni di quel tipo sono sempre abbastanza controverse: dare l’idea di una relazione di coppia come forma terapeutica (o, peggio, di una relazione di tipo patriarcale come quella tra professore saggio ed alunna malata e declinazioni simili, tipica della retorica di molte fiction all’italiana), offre l’idea distorta di un processo di cura che può sconfinare in un processo di dipendenza emotiva da un altro singolo, che sia il partner, il professore, il padre, la madre e via discorrendo. In negativo, chiaramente, significa che l’abbandono da parte dell’altro, porta in maniera quasi inevitabile al ritorno alla malattia.
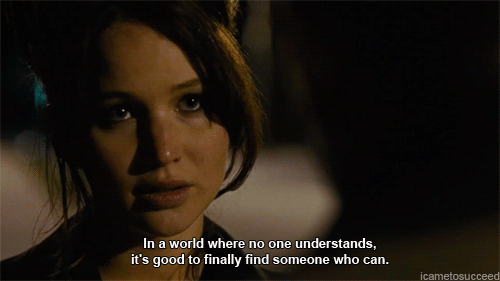
Si potrebbe pensare, naturalmente, che anche la collettivizzazione di cui parlo da tempo sia, per certi versi, un processo dipendente da altri. Tuttavia, molto banalmente, in questo caso non abbiamo un altro singolo e definito. In secondo luogo, decidere di collettivizzare il proprio disagio psichico ed inserire il proprio disagio psichico in una dimensione di condivisione vuol dire decidere di mettersi in gioco nel processo di resistenza, piuttosto che essere tirato fuori in maniera più o meno arbitraria da terzi definiti, quasi in una sorta di riproposizione psichica e personale del meccanismo politico della delega.
Chiaramente, pensare che la condivisione e la collettivizzazione siano da sole risolutive del disagio, è assurdo: come tutte le lotte politiche, anche quelle che si affrontano sul piano psicologico sono lunghe e difficili e come in tutte le lotte politiche, pensare di trovare un modus unico e corretto di pensare ed agire è pressochè impensabile. Iniziare però a ragionare su questi temi, soprattutto in un tempo storico in cui le politiche neoliberiste e la repressione incidono anche (e soprattutto) sulla nostra integrità psichica individuale e di conseguenza collettiva, è fondamentale.

credo comunque che ciò che racconta silver lining playbook possa verificarsi a volte..un rapporto di coppia (se non degenera in dipendenza) con qualcuno che ti comprende può davvero aiutare (non so se “curare” sia la parola giusta)
Ciao,
molto interessante il tuo articolo.
Anch’io ho sofferto di DCA, e nel processo di uscirne ho trovato molto disturbante il fatto che il modello di guarigione — a partire dalla psicoterapia, fino all’immaginario comune — fosse così estremamente individualistico. Guarire, alla fin fine, si risolverebbe in “lavorare su se stessi”. Questo è vero dell’impostazione medica/psichiatrica nei confronti del disagio, e trapela nella nostra cultura (specialmente negli US) nella forma del self-help più narcisistico (adesso diffusissimo anche su internet, vista la popolarità di articoli tipo 10 Semplici Mosse Per Scoppiare Di Autostima, e simili. Mi sembra che a te piaccia DFW, a volte mi chiedo che analisi avrebbe fatto lui di questo fenomeno!).
A me questa retorica è sempre stata stretta. Quando cercavo di uscire dal disturbo alimentare non cercavo altri mille consigli del ca**o per “mangiare intuitivamente”, cercavo altre persone e alleati nella mia stessa posizione con cui spalleggiarci a vicenda. Volevo mettere in relazione la mia malattia con il resto della mia cultura, discutere di valori occidentali, femminismo, tanti aspetti “politici” che non trovavano spazio nelle sedute di terapia. Volevo scambiare vissuti ed esperienze con i miei pari che avevano attraversato le stesse sofferenze, non sorbirmi le solite lezioncine sui vuoti criteri diagnostici del DSM.
Ho trovato qualcosa che assomiglia a quello che desideravo nell’auto mutuo aiuto, che è una forma di peer support semplice, “cheap” e poco burocratico che secondo me offre un’ottimo appiglio per chi vuole andare oltre la costrizione della propria esperienza nella retorica medicalizzante e appiattente (sui DCA, tra l’altro, non c’è nemmeno grande consenso scientifico sulle cause né i sintomi chiave).
Mi piace molto la rua reinterpretazione dei discorsi sulla “cura”. Io personalmente mi considero “in remissione” dal disturbo alimentare, proprio perché nella mia autonarrativa lo considero non come una malattia tipo virus passeggero, ma come una condizione neurobiologica che una volta attivata è cronica, e può essere messa in stato “dormiente” ma sempre con il rischio che si riacutizzi.
Comunque, grazie ancora per gli spunti di riflessione!
Un abbraccio
K.